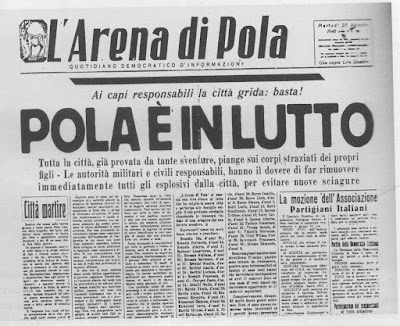Riportiamo questa bell'intervista di due anni fa alla giornalista e storica dell’arte Carla
Isabella Elena Cace, esule di terza generazione, autrice di «Foibe ed esodo. L’Italia negata» (edizioni Pagine)
da iltempo.it
Un libro per «illuminare» l’oblio planato per decenni sulle foibe e
sugli esuli istriani, giuliani e dalmati; per riempire le pagine vuote
che gli storici «marchiati» con un simbolo a senso unico non hanno mai
voluto scrivere; per risvegliare il ricordo di quanti patirono la furia
comunista senza che la loro patria, l’Italia, tendesse la mano per
accoglierli. Un libro intitolato «Foibe ed esodo. L’Italia negata»
(edizioni Pagine), scritto dalla giornalista e storica dell’arte Carla
Isabella Elena Cace, esule di terza generazione, che a 10 anni
dall’istituzione del «Giorno del Ricordo» ha voluto sigillare la fine di
un’epoca: l’epoca del silenzio e della verità negata, della storia
fasulla e omertosa e delle menzogne divulgate per decenni. Il libro
verrà presentato oggi alle 17 a Palazzo Ferrajoli, in piazza Colonna
355.
C’è un’Italia negata, un’Italia di vittime ignorate e di giovani, donne e vecchi «oscurati» per comodità storica e politica.
«L’eccidio dei connazionali di Venezia Giulia, Istria e Dalmazia è
stato il più grande dopo l’Unità d’Italia. Ed è surreale che sia stato
cancellato dalla coscienza nazionale. L’Italia aveva perso la guerra e
quelle popolazioni hanno pagato il prezzo di una guerra che era di tutti
gli italiani. Vivevano su un terra di confine e sono stati risucchiati
dalla potenza del maresciallo Tito. Dobbiamo dire con chiarezza che la
strage di questi italiani è avvenuta per mano di comunisti jugoslavi».
Nel dedicare il libro a suo nonno, Manlio Cace, ufficiale medico
esule da Sebenico, lei parla di «congiura del silenzio». Da parte di
chi?
«Per capirlo basta leggere i carteggi di Palmiro Togliatti con altri
funzionari del Partito comunista dai quali si evince chiaramente la
linea tenuta dal leader del Pci. Nel 1942 da Radio Mosca, Togliatti
invitava gli italiani ad unirsi ai partigiani jugoslavi. Questa cos’è se
non complicità nella pulizia etnica e nelle stragi delle foibe? Il Pci
fu sempre contrario ad ascoltare le ragioni dei giuliano-dalmati, per
motivi ideologici e per non incrinare l’amicizia con i popoli jugoslavi.
Il loro silenzio successivo fu assoluto. Il Pci ha avuto il monopolio
della cultura italiana, quindi dell’istruzione e della coscienza
storica. Sono stati loro, complice l’atteggiamento da Ponzio Pilato
della Dc, a decidere il racconto della nostra nazione, che cancellò una
strage di proporzioni bibliche non ancora svelata. Della "congiura del
silenzio", non va dimenticato, ha parlato anche il presidente
Napolitano».
Nel libro le responsabilità vengono assegnate anche a una Dc
«consociativamente» silenziosa, agli anglo-americani che «lasciarono
fare» in nome della realpolitik, ma anche alla Cgil.
«È innegabile. Quando gli esuli tornarono in Italia vissero un dramma
nel dramma. L’accoglienza per loro fu spesso spaventosa, soprattutto in
certe zone più ideologizzate, come l’Emilia Romagna. Arrivati a Bologna,
ad accoglierli c’erano militanti e simpatizzanti del Pci ma anche del
«sindacato rosso», che li definivano "cosiddetti esuli" e li accusavano
di fuggire non per evitare di vivere sotto una dittatura comunista ma
perché collusi col fascismo».
A dieci anni dall’istituzione del Giorno del Ricordo, il sindaco di
Roma, Ignazio Marino, ha cancellato i fondi per i viaggi degli studenti
su quei Luoghi della Memoria.
«Io mi vergogno del sindaco Marino. Tagliare completamente i fondi per i
Viaggi della Memoria è una scelta di una gravità inaudita. Negli ultimi
anni la presenza di studenti interessati e vogliosi di conoscere era in
costante aumento. Interrompere questo viaggio di preparazione culturale
è un’imperdonabile offesa».
Simone Cristicchi, per aver portato in scena il dramma delle foibe
con «Magazzino 18», su cui nel libro ci si sofferma, è stato «assalito»
anche da alcuni ragazzi che hanno interrotto il suo spettacolo
giudicandolo «revisionista».
«In certi ambienti di radicale militanza politica si vive per dogmi.
Non ci si interroga, si vive "contro" ogni cosa. E poi approfondire
richiede impegno intellettuale, mentre è molto più semplice scagliarsi
contro qualcosa. Non vogliono abbandonare la loro ideologia né
riconoscere che questi morti sono morti italiani».
Achille Occhetto, che ha guidato il partito comunista nella sua fase
conclusiva, ha «confessato» di non aver mai sentito parlare delle foibe
prima dell’89.
«Non credo che Occhetto non sapesse. Probabilmente non aveva compreso
col cuore, forse sapeva ma è passato velocemente alla pagina successiva
senza comprendere il dramma che gli si stava parando davanti».
Lo stesso Occhetto ha ammesso di essersi commosso assistendo a
«Magazzino 18» allo stesso modo in cui si commosse leggendo il diario di
Anna Frank.
«L’arte raggiunge il cuore. Possiamo fare mille conferenze e dibattiti,
ma i freddi numeri della storia e delle cifre non potranno mai avere lo
stesso effetto. L’arte fa commuovere, come fa commuovere Magazzino 18.
La storia degli esuli arriverà al cuore dagli italiani quando diventerà
spettacolo, romanzo, opera artistica».
Cosa deve cambiare affinché non accada più che migliaia di vittime innocenti vengano dimenticate dalla storia?
«Non bisogna mai stancarsi di raccontare, scompaginare questi lunghi
anni di silenzio. Oggi siamo al punto di partenza, non di arrivo. Solo
battendosi e lottando, la verità sulle foibe e sugli esuli verrà a
galla. Il mio libro è parte di questa battaglia».